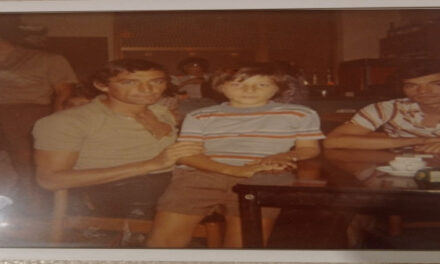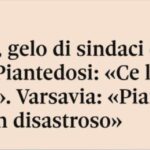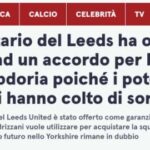Due conti, non solo per Conte

In queste settimane si è discusso molto degli interventi necessari a sostenere l’economia italiana, in modo che l’emergenza sanitaria, una volta terminata, non ci faccia passare senza soluzione di continuità in un’emergenza sociale, ancora più pericolosa e di lunga durata.
In realtà qualcuno ci è già dentro: penso in particolare a tutte le persone che dallo scorso 15 marzo non possono più lavorare, anche volendo. Si tratta di dipendenti di aziende che hanno dovuto chiudere, di lavoratori autonomi, di imprenditori (negozi ed attività artigianali) che dall’oggi al domani si sono trovati nell’incertezza di una fonte di reddito necessaria almeno a sopravvivere.
Molti si lamentano che gli interventi del Governo siano stati solo embrionali e siano insufficienti. Qualcuno invoca anche da noi l’adozione del criterio “elicopter money”, ovverosia una quantità di denaro data indistintamente a tutti, perché possano superare la crisi.
Già, ma come fare?
In questo momento siamo tutti anti-Europeisti. Dopo decenni in cui abbiamo vissuto “schiacciati” dalle logiche del rapporto debito/PIL, del patto di stabilità, dello spread, le contraddizioni di questa impostazione esclusivamente finanziaria dell’Europa sono emerse in maniera evidente.
Non voglio qui discutere se questo sentimento sia giusto o sbagliato. A mio parere è più che comprensibile, soprattutto perché gli Stati che appartengono all’UE “giocano” un campionato con regole diverse a seconda del colore della maglia e, guarda caso, coloro che si schierano dalla parte più intransigente sono anche quelli che maggiormente si sono organizzati per farsi i fatti loro.
Quello che però in questi casi bisogna evitare è di ragionare in maniera manichea e “sfruttare” una disgrazia come quella che sta accadendo per saltare dall’altra parte del fossato senza ragionare. Con questo intendo dire che così come il rigore eccessivo è un errore, altrettanto lo è a mio parere l’assenza di regole. Il debito pubblico non è un “male assoluto” come ci vogliono far credere, ma non è neanche un “bene assoluto”. Siamo tutti d’accordo che sarebbe meglio non averne, giusto? Perché il problema non è tanto l’esistenza del debito, ma come si è formato (cioè se i soldi sono stati investiti o sprecati) e quali conseguenze porta.
Comunque il ragionamento sarebbe troppo lungo e difficile (e, onestamente, non sono neanche sicuro di essere in grado di coglierne tutti gli aspetti), ma mi serve per introdurre l’obiettivo di questo post: cercare di identificare valutare l’impatto delle soluzioni che sono state messe in pista dal Governo, per capire a che cifra siamo arrivati.
Prima di partire una premessa importante: non credo esista (almeno io non l’ho trovata) una fonte che consenta di avere tutti i dati di cui abbiamo bisogno. Quindi i numeri che leggerete e sui quali mi sono basato sono un collage di informazioni non sempre allineate fra loro: alcuni vengono dalle rilevazioni ISTAT e si riferiscono al 2017, altri (quelli sull’occupazione) sono aggiornati a fine 2019, altri ancora sono reperiti in studi di settore pubblicati negli ultimi 2 anni. Non si parlano, quindi, direttamente fra loro, ma possono aiutarci ad identificare degli ordini di grandezza. Per quanto riguarda gli scenari che ho immaginato, anche in questo caso non ci sono basi scientifiche o studi: prendetele come una delle mille possibili ipotesi, la mia. Infine: siate clementi, perché il ragionamento è necessariamente “superficiale”. È solo un esercizio condiviso, senza particolari.
Il problema non sanitario
Il problema più immediato (non sanitario) che ci troviamo ad affrontare è la tenuta della capacità di sostentamento della popolazione.
Oggi il numero di persone che stanno iniziando ad avere difficoltà a causa dell’epidemia (dimenticando per il momento quelli che i problemi li avevano già prima, quindi in particolare disoccupati e poveri) è destinato ad aumentare con cadenza settimanale, perché chi ha perso (o sta per perdere) la propria fonte di reddito inizia a consumare eventuali risparmi – se ne aveva – e rischia di trovarsi senza possibilità di sostentamento per la famiglia da un momento all’altro.
Per il momento questo problema riguarda prevalentemente lavoratori autonomi, artigiani e piccole e medie aziende che non appartengono all’elenco di coloro che sono stati autorizzati a lavorare: forse riescono a mantenersi in piedi ancora per un po’, ma immagino abbiano dovuto bloccare i pagamenti ai propri fornitori, con l’effetto di scatenare un effetto domino a breve (chi non viene pagato, a sua volta non ha fondi per pagare).
L’effetto “immediato” sulle tasche degli italiani
Incrociando i dati disponibili, la situazione dovrebbe essere abbastanza simile a quella rappresentata nella tabella.

Abbiamo poco più di un terzo della popolazione italiana che, salvo cataclismi, non sta subendo ne’ subirà alcun effetto negativo dal punto di vista economico: sto parlando dei dipendenti pubblici e dei pensionati per i quali lo stipendio (o la pensione) arriverà ogni mese, puntualmente.
Più complesso estendere il ragionamento agli occupati del settore privato. Proviamoci comunque partendo dalla ripartizione per tipo di inquadramento (dipendente/autonomo) e per dimensione dell’azienda che paga loro lo stipendio.

In questo caso le variabili in gioco sono molteplici. La prima osservazione da fare è che una quota significativa del totale (14,8 mln di persone, quindi il 75%) sono lavoratori dipendenti. Con le modifiche introdotte dal decreto di fine marzo, tutte le aziende avranno accesso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione).
Certo, la cassa integrazione porta un’entrata mensile – se l’azienda è completamente ferma – che non arriva a 1.000 Euro, però si tratta di soggetti per i quali – tecnicamente – lo Stato è già intervenuto con una primissima forma di tutela, che sta già iniziando ad essere usata. Possiamo ipotizzare che buona parte dei dipendenti delle aziende che hanno già dovuto cessare la produzione si trovino già ad usufruire di questo ammortizzatore sociale (e, quindi, che abbiano un effetto negativo sul proprio reddito “normale”), mentre una quota delle altre aziende ricorreranno a questo strumento nel corso del mese di aprile, sia perché già in difficoltà dalla riduzione del lavoro, sia per questioni preventive (ometto quelli – e purtroppo ce ne saranno – che sfrutteranno la situazione anche se non ne avrebbero bisogno, solo per ridurre i costi).
Anche in questo caso, però, credo ci saranno delle aziende che non ricorreranno agli ammortizzatori sociali. Se dovessi “indovinare” una cifra, direi che alla fine:
- 20% di dipendenti che non avranno alcun effetto dalla crisi (cioè continueranno a prendere lo stipendio regolarmente);
- 30% subirà un effetto parziale (cioè con una cassa integrazione che verrà usata solo per parte del mese);
- 50% andrà in cassa integrazione per tutto il periodo.
Diverso il caso dei lavoratori autonomi (ricordiamoci che in quei numeri ci sono anche commercianti ed artigiani, che sono molto più esposti alla crisi ed all’immediatezza del problema, soprattutto nella fascia che appartiene agli scaglioni fra 0 e 20 dipendenti). Anche ipotizzando che un 50% stia continuando a lavorare parliamo di quasi 2,6 mln di persone, che non hanno accesso ad ammortizzatori sociali e che solo in parte sono destinatari del contributo da 600 Euro/mese in corso di erogazione.
Infine va considerato che gli effetti si riverbereranno anche sulla popolazione inattiva “per scelta” (secondo la classificazione INPS si tratta prevalentemente di studenti o persone che non cercano lavoro per scelta). Poiché dipendono economicamente da altri, li classificheremo per rischio le stesse percentuali.

Il primo dato, positivo, che emerge è che il 64,5% della popolazione italiana che non dovrebbe subire alcun impatto (o subirlo in minima parte) immediato dalla crisi in corso.
Una quota comunque rilevante (13,3 mln di persone), invece, sarà maggiormente colpita (lavoratori in cassa integrazione al 100% e beneficiari dell’assegno di 600 Euro), nonostante in parte sotto tutela.
Gli altri, quelli che erano senza protezione già prima dell’inizio della crisi, vedranno la loro situazione invariata o, ragionevolmente, in peggioramento.
La tenuta finanziaria delle aziende
Un secondo problema (secondo solo perché impiega qualche settimana in più a manifestare i suoi effetti) sarà invece l’impatto della crisi sulla capacità delle aziende di far fronte ai propri impegni verso il personale dipendente (dove, però, abbiamo visto che le tutele sono già state attivate) e verso i fornitori. Se questi non vengono pagati, andranno in crisi di liquidità ed inizieranno a non pagare a loro volta.
Questo aspetto è più complesso da affrontare. Se non ho capito male, con un decreto legge (in arrivo lunedì prossimo) si prevederà l’accesso delle aziende a finanziamenti erogati dalle banche con una garanzia dello Stato: credo che l’ipotesi sia di basare il finanziamento sul fatturato di 2/3 mesi, in modo da dare ossigeno immediato con denaro che possa essere usato per far fronte agli impegni e non bloccare tutto. Immagino che sia previsto un tasso di finanziamento pari allo 0% e, spero, un periodo di 5 anni a partire dal 2022, per dare tempo alle aziende di risollevarsi.
Per cercare di capire di quali valori parliamo, proviamo ad affidarci ai ISTAT del 2017 secondo cui, al netto delle società finanziarie e di alcune strategiche per le quali il dato viene oscurato, il fatturato annuale del settore privato italiano è di 3 mila di miliardi di Euro, pari a circa 253 miliardi di euro al mese.

Anche in questo caso non è credibile che tutte le aziende abbiano necessità di ricorrere al credito. Non avendo dati a disposizione proveremo ad immaginare che una quota pari al 35% di questo fatturato annuale derivi da aziende che non avranno accesso a questi strumenti, sia perché quotate in Borsa, sia perché dotate di mezzi autonomi per sostenere l’impatto della crisi (a mio parere si potrebbe alzare questo valore, ma preferisco essere prudente visto che i furbi sono sempre in agguato): parliamo di circa 1.980 miliardi di Euro su base annua.
Non so se lo Stato riuscirà a sburocratizzare l’intervento in maniera tale da far pervenire il denaro in tempo. Ad esempio la scelta di rilasciare una garanzia solo parziale (al massimo al 90%, per le aziende più piccole) è secondo me un errore, perché lascia le aziende richiedenti in balia delle procedure delle banche: dovendo assumere una quota di rischio – benché minima – provvederanno infatti a fare delle istruttorie chiedendo tonnellate di documenti ed allungando i tempi di erogazione.
Attenzione: per quanto io sia normalmente critico del modo di “fare banca” in Italia, va anche detto che loro si muovono all’interno di un quadro normativo che – sul recupero del credito – non le tutela, così come non tutela le aziende. Il problema storico dell’Italia (se qualcuno di voi ha provato a fare un decreto ingiuntivo lo sa bene) è infatti che i tempi di recupero dei propri crediti sono infiniti e questo diventa un ostacolo ad una maggiore flessibilità. Purtroppo non è questo il momento in cui si potrà fare qualcosa per risolvere questo tema, quindi non so come lo Stato possa ovviare se non estendendo al garanzia al 100%, cosa che a quel punto toglierebbe problemi (ed alibi) alle banche.
Quanto costa? Ce lo possiamo permettere?
Fino a qui abbiamo cercato di identificare le soluzioni che sono state già messe in pista dal Governo (con tempi più o meno lunghi di reazione, vedasi il problema del sito dell’INPS che non reggeva il carico di richieste).
Se volessimo provare a fare un esercizio per simulare l’impatto di queste misure sui conti pubblici (con tutte le premesse sull’attendibilità dei dati che vi ho fatto prima e ricordando che gli scenari sono un’elaborazione senza basi scientifiche) forse potremmo spaventarci.
- La cassa integrazione
Abbiamo ipotizzato che a fronte di 14,8 mln di dipendenti del settore privato, ve ne siano 4,4 mln che usufruiranno della cassa in maniera parziale (ipotizziamo 30%) e 7,4 mln che invece la useranno completamente. Considerando che la cassa comporta anche il riconoscimento dei contributi pensionistici “figurativi”, possiamo ipotizzare che per ogni dipendente in cassa, lo Stato abbia un esborso di circa 1.250 Euro, fra denaro che viene erogato e contributi che vengono riconosciuti.
L’impatto di questo ammortizzatore sociale, secondo il nostro scenario, sarebbe di circa 11 miliardi di Euro al mese. Immaginando una durata di 2,5 mesi, parliamo di 27,5 miliardi di Euro complessivi.
- Il contributo agli autonomi
Qui la valutazione è più difficile, perché per coloro che sono iscritti ad una cassa di settore è questa che dovrebbe intervenire. Non avendo elementi per giudicare, proviamo ad ipotizzare che sia erogata a tutti coloro che abbiamo ipotizzato ricadere nella casella “impatto forte ma protetto”, cioè 3,5 mln di persone. Anche in questo caso, immaginando che il costo effettivo non sia di 600 ma di 800 Euro a persona, parliamo di 2,1 miliardi di Euro al mese. Oltre a questo, temo che le casse di settore possano avere delle grosse difficoltà nel sostenere l’impatto, quindi immagino che lo Stato dovrà intervenire a supporto (ipotizzo un altro miliardo di Euro al mese).
- Il finanziamento delle aziende
Sulla base della nostra premessa, il fatturato annuo da considerare è di 1.978 miliardi di Euro. Se ipotizzassimo una “copertura” di due mesi parliamo di 330 miliardi di Euro (che diventano 494 se la copertura passa a tre mesi).
La grossa differenza con i due valori visti in precedenza, però, è che in questo caso non sarebbe denaro a fondo perduto, ma una garanzia rilasciata alle banche che erogano le linee di credito. Allo Stato rimarrebbe il costo delle commissioni di erogazione e degli interessi da riconoscere alle Banche, che seguendo il nostro scenario (5 anni, a partire dal 2022) potrebbero essere intorno ad un 6/7% complessivo dell’importo. Il conto per le casse dello Stato sarebbe quindi intorno ai 10 miliardi di Euro per ciascun mese di copertura concesso, e quindi compreso fra 20 e 30 miliardi di Euro. A questi andranno aggiunti tutti i finanziamenti che non saranno restituiti (credo che, al di là degli interventi, una quota delle aziende avrà comunque delle difficoltà e potrà fallire o comunque attivare delle procedure concorsuali) e per i quali lo Stato dovrà materialmente intervenire con le banche per estinguere i debiti.

Questi tre primi interventi, quindi, potrebbero avere un costo complessivo di circa 60 miliardi di Euro, che andrebbero a fronteggiare solo questa prima fase dell’emergenza.
La vera sfida sarà dopo: rivedere l’impostazione dell’Europa non vuol dire farsi autorizzare queste spese (di fatto, lo sono già), ma concordare un nuovo modo di concepire lo sviluppo economico che tenga conto delle necessità di rispettare dei vincoli comuni, senza però che questi diventino l’unico elemento di valutazione della politica economica nazionale.
In parallelo, però, noi Italiani dobbiamo fare in modo di non sprecare questa opportunità che, sebbene non scelta ma proveniente da una tragedia, potrebbe cambiare significativamente il nostro futuro in positivo.
Ma solo se, per una volta, sapremo imporci da soli la necessaria dose di rigore, che andrà studiata per essere “nostra”, in modo che poi la si senta tale e la si rispetti, come cittadini.